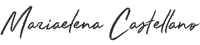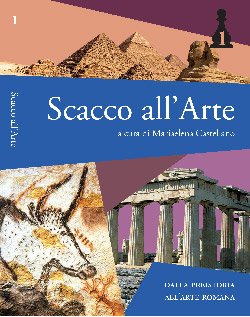Michelangelo Merisi nasce nel 1571 a Milano, in un periodo segnato dalla Controriforma e dall’incalzare della peste.
Suo padre è architetto decoratore presso la corte di Francesco I Sforza, marchese di Caravaggio, la cittadina bergamasca da cui hanno origine i Merisi e da cui Michelangelo prenderà il nome d’arte. Quando nel 1576 l’epidemia si abbatte sul capoluogo lombardo, la sua famiglia segue il marchese riparando a Caravaggio, ma la peste infuria anche lì e ne sono vittima il padre, uno zio e il nonno.
Quando, dopo qualche anno, il giovane fa ritorno a Milano, dà già prova della sua talentuosa disposizione alla pittura e nel 1584 viene indirizzato nella bottega di Simone Peterzano, noto pittore locale, allievo di Tiziano. A fargli sottoscrivere questo percorso è l’intercessione della nobile famiglia Colonna, subentrata nel marchesato di Caravaggio dopo la precoce morte di Francesco I Sforza.
La protezione dei Colonna non verrà mai meno all’indole ribelle e inquieta del Merisi e in più di un’occasione gli salverà la vita. In particolare, Costanza Colonna, vedova di Francesco I Sforza, lo appoggerà in tutti i modi, seguendolo anche in alcuni dei suoi spostamenti, fino al punto di compromettere la sua rispettosa posizione.
È dunque in Lombardia che avviene la primissima formazione di questo pittore anticonformista, chiuso a qualsivoglia compromesso, la cui opera irromperà nel variegato panorama artistico a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, senza collegarsi ad alcun movimento già esistente, ponendosi piuttosto come un unicum, come il grido rivoluzionario di chi ha una visione personale del mondo.
Del resto, in questi anni lo scenario artistico lombardo è dominato da una più libera impostazione realistica, lontana dai modi leziosi e accademici della Maniera, con una spiccata propensione alla resa dei contrasti chiaroscurali e alla rappresentazione di scene notturne.
Il maestro Peterzano fonde il gusto manierista con queste tendenze realistiche che tanto influenzano il Caravaggio, particolarmente attento ai nuovi modi di trattare la luce. Egli matura così un linguaggio atto a raffigurare il “vero naturale” senza l’intermediazione dei modelli ideali: la sua arte trae spunto dalla realtà più viva, dagli aspetti più comuni della vita quotidiana, senza subire alcun condizionamento dalle gerarchie di generi e valori.
Forte di tali esperienze e di un singolare estro creativo, nel 1592, venuta a mancargli anche la madre, lascia il capoluogo lombardo e, già ben padrone della tecnica, impaziente di esprimere la sua virtuosa e appassionata pittura, approda a Roma, ambita capitale artistica, votata in quegli anni a un gran fermento culturale.
Caravaggio è attratto da questo ambiente capace di offrirgli maggiori opportunità artistiche e tenta la fortuna. Tuttavia, la sua ispirazione realista non suscita grande interesse nella città dei papi, più incline al gusto manierista del tempo, e dunque per sopravvivere egli deve adeguarsi a esigenze diverse. Sono anni difficili, in cui si ritrova solo e privo di sostegni economici; vive di stenti nei sobborghi romani, frequenta quartieri poveri e malfamati, dove incontra un’umanità vera, provata dalla sofferenza e dalla miseria.
Saranno proprio questi uomini di strada a ispirare l’arte del Caravaggio, segnata da un potente realismo e da sorprendenti effetti luministici. Il suo linguaggio, pervaso com’è dal desiderio di narrare il vero, si distingue per la capacità di immortalare attimi di vita reale, permeati da un profondo senso di umanità. Si tratta di scene spesso caratterizzate da un’intensa drammaticità, in cui si riflette l’animo tormentato dell’artista. Le sue precarie condizioni di vita, così come l’infanzia difficile, marcata dall’infuriare della pestilenza e dalla prematura perdita di entrambi i genitori, acuiscono la sua personalità inquieta e spregiudicata, che lo induce a condurre una vita piuttosto irregolare, non immune da scandali e maldicenze.
D’indole fiera e ribelle, viene spesso coinvolto in risse e affari ambigui, che gli costano ripetuti arresti e diffide.
Al pari della sua vita irruenta, anche la pittura del Caravaggio è scandalosa: è impetuosa e forte, proprio come lui, artista veloce come pochi, geniale nelle scelte iconografiche e compositive, nonché dotato di una gran sensibilità espressiva.
Se i più non accettano la stravaganza del giovane lombardo, bollato come “l’artista maledetto”, non pochi risultano i personaggi che ne apprezzano l’arte, giungendo a rischiare la loro posizione influente pur di proteggerne l’attività.
Tra questi, figura monsignor Pandolfo Pucci, beneficiario di San Pietro, che, affascinato dalla pittura del Merisi, gli offre vitto e alloggio, purché egli si presti a copiare dipinti religiosi. Si è ipotizzato che a introdurlo nella residenza del prelato sia stata la marchesa Colonna, approdata anche lei a Roma.
Probabilmente per il carattere difficile di monsignor Pucci, dopo diversi mesi, nella primavera del 1593, Caravaggio preferisce prenderne le distanze, ritrovandosi così di nuovo in strada, tra ristrettezze economiche e problemi di salute.
Secondo alcuni biografi contrae la malaria e trova ricovero presso l’Ospedale della Consolazione, struttura destinata alla cura dei poveri. Vive un’esperienza forte, la malattia lo segna profondamente, come attesterebbe un suo dipinto, “Il Bacchino malato”, forse un suo autoritratto al tempo della convalescenza. Si è inoltre ipotizzato che un’eco del tormento vissuto durante la malattia emergerebbe anche nella più tardiva “Morte della Vergine”.
Una volta ripreso, Caravaggio approda nell’attiva bottega del Cavalier d’Arpino, pittore di gran fama negli ambienti della committenza romana, che lo impiega nella realizzazione di finiture di fiori e frutta, preludio di un genere pittorico che in seguito verrà definito “natura morta”.
L’artista opera con fervore dedicandosi anche ad altri soggetti, quali “Bacco”, “Ragazzo morso da un ramarro” e “La fuga in Egitto”, tutti dipinti tra il 1594 e il 1595.
Inizia così a farsi un nome e tra i suoi estimatori figura Valentino, noto mercante d’arte della città, che gli procura la protezione del cardinale Francesco Maria Del Monte, raffinato e potente mecenate.
Per lui Caravaggio dipinge numerose opere, tra cui il “Canestro di frutta” (tra il 1597 e il 1600 circa) e la “Testa di Medusa” (1596-98).

Quest’ultima è segnata da un’intensa emotività drammatica. Essa è dipinta su di una tela applicata a uno scudo bombato di forma circolare, a simboleggiare lo scudo sacro che Atena prestò a Perseo per uccidere la Gorgone; su di esso, infatti, secondo il mito, la dea attaccò la testa decapitata della vittima. L’urlo di terrore della Medusa del Caravaggio esprime lo sgomento provato nel momento della decapitazione e la tensione è acuita dai fiotti di sangue che schizzano dal collo.

In “Canestro di frutta” Caravaggio svela il suo talentuoso virtuosismo tecnico: si notino gli effetti chiaroscurali modulati sulla fonte di luce proveniente da sinistra, la sorprendente resa realistica della cesta e della frutta, nonché la studiata sporgenza dell’oggetto, quasi in bilico, come rivela l’ombra proiettata verso il basso.
L’artista rinuncia all’ideale classico di bellezza assoluta e propone una natura decomposta e sfiorita, dove le foglie rinsecchite, gli acini d’uva ormai ben maturi e, ancora, il particolare della mela bacata, alludono alla transitorietà della vita.
Nel 1599, sempre per intercessione di Valentino, l’artista riceve la sua prima importante commissione religiosa e realizza tre grandi quadri per la cappella Contarelli, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma.
La scelta di sostituire la tradizionale decorazione ad affresco con ampie tele dipinte ad olio rivela la fiera indipendenza del Caravaggio. La tecnica della pittura ad olio soddisfa la sua esigenza di operare con celerità e gli consente di modulare gradualmente le sfumature, attingendo da un’ampia gamma cromatica di notevole brillantezza; ne deriva una pittura dagli intensi effetti luministici in cui il modellato risulta esaltato dai sapienti giochi di ombreggiatura.
Anche la scelta dei soggetti raffigurati mostra la vena anticonformista del pittore lombardo.
Nella “Vocazione di San Matteo” l’evento è ambientato in uno scantinato che ricorda le osterie della Roma del tempo e che probabilmente va identificato con un banco delle tasse, in riferimento alla professione di esattore di Matteo.

I personaggi vestono abiti contemporanei, tutti eccetto il Cristo e San Pietro, che appaiono nella parte destra del dipinto. L’apostolo copre la figura del Salvatore, di cui s’intravede il capo coronato da un’esile aureola e l’espressione risoluta, riecheggiata dal gesto perentorio del braccio steso per chiamare a sé Matteo. Un potente getto di luce evidenzia il tutto; una luce dunque divina ma, al tempo stesso, naturale, proveniente da un’immaginaria porta situata all’estrema destra, al di fuori del dipinto, situata più in alto, a indicare l’ingresso rialzato della taverna, da cui presumibilmente sono entrati i due uomini. Quasi come fosse un varco dimensionale che mette in connessione il passato storico al presente dell’artista, un presente in cui può ancora avvenire la chiamata del Cristo. Il messaggio salvifico divino è dunque sempre possibile, in ogni tempo e in ogni spazio, persino in un’osteria dei quartieri più malfamati della città o in un banco delle tasse. Chi risponderà alla vocazione? Matteo indica se stesso, come per ricevere conferma che la chiamata del Cristo sia rivolta proprio a lui; due giovani si voltano, incuriositi, mentre gli altri due personaggi continuano avidamente a contare il denaro.
Caravaggio rivela così la cecità degli uomini, distratti dai beni materiali e, pertanto, incapaci di riconoscere e seguire la salvezza divina. Il libero arbitrio consente loro di non rispondere alla chiamata, di percorrere un’altra strada.
L’intensa vena narrativa della “Vocazione di San Matteo” non viene colta appieno e non si risparmiano le polemiche. Anche gli altri due dipinti, “San Matteo e l’angelo” e “Il martirio di San Matteo”, non sono esenti da critiche per le audaci scelte innovative dell’artista, tanto da far parlare di realismo dissacrante.
La tela di “San Matto e l’angelo” viene addirittura rifiutata dai committenti, poiché il Santo appare come un rozzo contadino scalzo, con i piedi a cavalcioni, aiutato nella scrittura dall’intervento dell’Angelo, ritenuto troppo confidenziale. L’opera esposta oggi nella cappella corrisponde dunque a una seconda versione, mentre quella originaria è andata purtroppo distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale.
Critiche e ingiurie accompagnano anche le due successive tele realizzate nel 1601 per la cappella Cerasi, nella Chiesa di S.Maria del Popolo, a Roma.
Le prime versioni di entrambe le opere vengono infatti rifiutate e le tele che vediamo oggi esposte nella cappella sono accolte non senza ritrosie ed esitazioni.

Nella “Crocifissione di San Pietro” l’impetuosa brutalità del “Martirio di San Matteo” cede il passo a una visione più pacata, ma intrisa di amara rassegnazione. I carnefici sono presi dalla sforzo del sollevare la croce a cui è inchiodato Pietro, il quale con un gesto di sorprendente naturalezza alza e rotea il capo, il volto contratto a smorzare il dolore del martirio.
Anche la seconda versione della “Conversione di San Paolo” viene giudicata provocatoria e irrispettosa del sacro. Paolo era un persecutore e, mentre era in viaggio verso Damasco, sente la voce del Cristo e viene accecato dall’intenso bagliore della rivelazione divina. L’evento lo porterà così a convertirsi al cristianesimo. Nel dipinto l’artista raffigura il momento più concitato, quando Paolo giace riverso a terra, gli occhi ancora chiusi per lo sfolgorio luminoso. L’intera scena è però dominata dalla gran mole del destriero che lo trasportava, qui reso tramite un virtuoso saggio di rappresentazione anatomica.

A chi lo accusa di aver dato più importanza al cavallo piuttosto che al Santo, Caravaggio ribatte che l’animale è nella luce di Dio, eletta dunque a vera protagonista dell’opera.
L’artista prende a male le polemiche sorte intorno alle sue opere e torna a condurre una vita irregolare, segnata da disavventure problematiche e da un arresto per atti diffamatori nei confronti del pittore Giovanni Baglione, suo futuro biografo.
Liberato dal carcere grazie all’intervento di alcuni cardinali suoi estimatori, riceve l’incarico di dipingere la “Madonna dei pellegrini”, ma la scelta di utilizzare come modella Lena, una prostituta di piazza Navona, gli procura altri guai. Un notaio cliente della ragazza, infatti, viene ferito dal pittore, probabilmente per una rissa scatenata dalla gelosia di uno dei due. Ricevuta la denuncia, Caravaggio ripara per alcuni mesi a Genova, per poi far ritorno nella capitale, grazie all’improvviso ritiro dell’atto accusatorio. Termina la “Madonna dei pellegrini” e si dedica alla realizzazione di altri dipinti, tra cui la nota “Morte della Vergine”, risalente al 1606, anch’essa rifiutata dai committenti, i frati dell’ordine dei Carmelitani Scalzi.
L’opera colpisce per il suo scabroso senso di verità: la Vergine giace su una tavola con i piedi scalzi e divaricati, irrigiditi dal torpore della morte, i capelli scompigliati, il volto pallido, abbandonato al sonno eterno; le mani non sono ancora giunte, poiché ha appena spirato; un braccio è steso, adagiato sul cuscino, l’altro è piegato sul ventre gonfio, a simboleggiare la perenne fecondità della Madre di Dio.

Intorno a Lei i discepoli e la Maddalena piangono, consumati dallo strazio della perdita, provati da una sofferenza vera, autentica, rivelata dal potente fascio di luce che entra dalla sinistra, irrorando i dolenti di sprazzi, fino a posarsi sul volto senza vita della Madonna.
In alto, un grande drappo rosso sospeso al soffitto infonde teatralità alla scena, già pervasa da una struggente aura luttuosa.
L’opera riceve un secco rifiuto non solo per l’indecorosa immagine della Vergine, ma anche perché pare che l’artista si sia servito come modella di una prostituta annegata nel Tevere. La visione di quel cadavere con il ventre colmo d’acqua gli ha rivelato la drammaticità della morte, trasposta d’istinto nello spazio della tela.
Caravaggio svela così la verità della morte e, insieme ad essa, la verità del dolore, qui inteso come sentimento umano e dunque privato di quella doverosa e ossequiosa solennità, così cara alla tradizione iconografica religiosa. La sua audacia dissacrante non può essere certo accolta nell’ambiente rigoroso del tempo.
Inoltre, dopo il rifiuto della “Morte della Vergine”, un tragico evento sconvolge la vita dell’artista: il 28 maggio 1606, durante una partita a pallacorda, o comunque nei pressi di dove si pratica quel gioco, litiga con un tal Ranuccio Tomassoni e lo scontro termina con l’uccisione dell’uomo. Ne consegue una condanna capitale di decapitazione: a Caravaggio non resta che lasciare Roma.
Inizia così l’ultimo travagliato periodo della sua avventurosa esistenza: egli peregrina da una città all’altra, continuando a dipingere con sorprendente fervore e rapidità.
Aiutato dal principe Filippo I Colonna, dapprima ripara a Napoli, dove resta per circa un anno e, tra le varie opere, realizza una toccante “Flagellazione”, in cui il corpo incurvato del Cristo, scolpito dalla luce, pare prendere vita per emergere dall’oscurità del fondo.

Da Napoli Caravaggio si sposta poi a Malta, con l’intento di entrare nell’ordine dei Cavalieri dell’isola, in modo da garantirsi l’assoluzione dalla pena capitale.
Qui, nel 1608, realizza la sua tela più grande, la “Decollazione di San Giovanni Battista”, una cruenta raffigurazione in cui il Santo giace a terra, sgozzato dal suo boia, in procinto di tagliargli la testa con un pugnale. Dal capo già reciso sgorga un fiotto di sangue che l’artista utilizza per firmarsi con il suo nome di battesimo, Michelangelo. È l’unica sua opera autografa, come un grido di espiazione del delitto di cui si era macchiato, come una condanna inevitabile, incisa col sangue.
Caravaggio, anche se insignito dell’ambito titolo di Cavaliere, a dimostrazione dell’alta protezione che ancora lo accompagna, è costretto a fuggire anche da Malta, imbattutosi con ogni probabilità in un’ennesima lite.
Ripara quindi in Sicilia, lasciando anche qui dipinti segnati da un’intensa vena drammatica. Torna poi di nuovo a Napoli, dove alla fine del 1609 dipinge un “David con la testa di Golia” che provvede a inviare a Roma, al cardinale Scipione Borghese, insieme alla richiesta di grazia.
Il David di questa tela è un giovane dallo sguardo pietoso, irradiato da un potente getto di luce che lo fa emergere dal fondo oscuro. Regge la testa mozzata del gigante, nelle cui fattezze si tende a riconoscere l’ultimo disperato autoritratto del pittore maledetto. Il volto è invecchiato, provato dalle tormentate vicende degli ultimi anni; la fronte aggrottata, segnata dai solchi delle rughe; gli occhi ancora aperti, stanchi, come se guardassero verso un punto indefinito; le labbra dischiuse, come in procinto di gridare l’ultimo appello di salvezza.
Verso la metà dell’anno successivo, Caravaggio parte alla volta dello Stato Pontificio, speranzoso di ricevere l’agognato perdono, ma nelle traversie dell’ultimo viaggio della sua rocambolesca esistenza, muore di stenti e, forse, di malaria, abbandonato su una spiaggia.
Si conclude così la vita di un artista che incide profondamente sul percorso della pittura italiana ed europea del Seicento e dei secoli a venire. Pur avendo lavorato da sempre in solitaria, senza circondarsi di alunni o seguaci, infatti, l’intensa veridicità della sua pittura non passa inosservata ed è destinata a influenzare notevolmente il panorama pittorico del tempo.
Ma se la sua opera resta ben viva nella memoria degli artisti delle successive generazioni, non è così per il ricordo della sua persona, così irriverente e scandalosa, troppo scomoda per quei tempi. Così, mentre i suoi dipinti vengono ammirati e copiati condizionando gli esiti della pittura, il nome di Caravaggio viene dimenticato e cade man mano in un oscuro oblio.
Sarà il critico d’arte Roberto Longhi, nella metà del XX secolo, a restituirgli la giusta fama, ricostruendone gran parte delle vicende biografiche e provvedendo ad attribuire al suo nome capolavori relegati nell’anonimato per più di tre secoli.
Da allora, un punto di non ritorno, la sua notorietà non conosce battute d’arresto.
Il pittore maledetto non si è limitato a sprigionare luci e colori con straordinaria perizia tecnica, o a modellare i soggetti tramite potenti contrasti chiaroscurali: la forza della sua arte va oltre l’abilità di ogni possibile virtuosismo tecnico.
I personaggi del Caravaggio paiono prendere vita, animati come sono da un irruente anelito di energia, ravvisabile persino nell’incarnato della loro pelle, dotato com’è di una muscolatura palpabile e di un’ossatura percepibile, rese tali attraverso i sapienti giochi delle ombreggiature. E poi, i volti. I volti dei personaggi del Caravaggio sono profondamente umani; esprimono tutta la drammaticità che sono chiamati a vivere, svelano l’essenza di un istante ricco di tensione, immortalato nella tela, come nel fermo immagine di un rapido e incalzante susseguirsi di scene. Così come rapida e incalzante è la sua pittura, eppure sempre capace di infondere veridicità, sempre capace di gridare la sua personale, immensa, visione della vita.
Mariaelena Castellano
LA NATURA MORTA
Al pari della scena di genere, anche la natura morta propone immagini reali, svincolate dalle tematiche sacre e dai soggetti storici e mitologici. Per natura morta s’intende una rappresentazione di oggetti, priva di figure umane: fiori, vasellami, tavole imbandite, strumenti musicali.
Si tratta di un genere minore diffuso dal Nord Europa e ritenuto inferiore rispetto alle altre tematiche, nonostante indichi l’interesse per l’indagine scientifica della realtà. Ad apprezzarlo sono in particolare le committenze borghesi, amanti dei quadri di piccolo formato, anche per la maggiore facilità d’acquisto. Spesso le nature morte celano significati simbolici, come si evince dai dipinti raffiguranti teschi, chiaro riferimento alla caducità dell’esistenza, come monito a vivere in rettitudine.