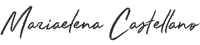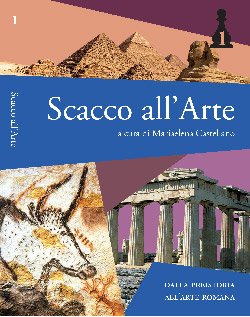Gli scultori attivi nell’età ellenistica propongono una forte interazione dell’opera con lo spazio circostante, puntando a un più diretto coinvolgimento dello spettatore: chi osserva è invitato a girare intorno all’opera, per godere di una fruizione più completa, alimentata dai differenti punti di vista. Tale orientamento spiega il grande riscontro ottenuto dalla tipologia del gruppo scultoreo, più votato a effetti scenici e a concitati ritmi narrativi.
In questo periodo emerge un accentuato gusto per il dinamismo e per l’uso di una tecnica virtuosistica, alimentata da una grande attenzione ai dettagli, in particolare agli effetti di stoffe svolazzanti e panneggi frastagliati. Questi sviluppi evolutivi, uniti a una marcata predilezione per la resa del pathos, rappresentano i capisaldi della produzione scultorea del tempo, vicina soltanto formalmente al linguaggio classico, ormai rielaborato secondo nuovi canoni rappresentativi, improntati alla spettacolarità e alla drammaticità.

Un esempio rinomato di plastica ellenistica è fornito dalle statue bronzee che ornavano il Grande Donario, monumento celebrativo commissionato intorno al 230 a.C. dal sovrano Attalo I, in memoria della vittoria di Pergamo sul popolo dei Galati.
Il gruppo originale, non pervenuto, era posto su una base circolare e rappresentava i combattenti sconfitti, disposti uno sull’altro secondo un costrutto piramidale che culminava, in alto, nella toccante effigie del “Galata suicida”.
Di quest’ultima, così come della statua del “Galata morente”, sono state realizzate due copie marmoree in età romana, che ci consentono di cogliere l’intensa drammaticità che caratterizzava il complesso scultoreo di Pergamo, caratterizzato da un profondo senso di rispetto per i vinti, degni di eroica grandezza e commiserati per il loro amaro destino.

Spostandoci nell’isola greca di Rodi, centro culturale vivo e pulsante, segnalo altri capolavori del tempo: il gruppo di Laocoonte con i figli(*) e il Supplizio di Dirce conosciuto anche come Toro Farnese(*).
Di scuola rodia risulta anche la celebre Nike scolpita intorno al 190 a.C. e rinvenuta in più frammenti, nel 1863, nell’isola di Samotracia. Nonostante le condizioni rovinose della statua, acefala e priva di braccia, se ne percepisce appieno la prorompente energia vitale: la Vittoria alata si posa sulla prua di una trireme da guerra, probabilmente con l’intento di incoronare il vincitore di una battaglia navale. La dea sembra ancora in movimento, le ali sono spiegate, come a suggerire il suo improvviso arrivo, in una scenografica aura teatrale. La veste si anima gonfiandosi in fitte pieghettature ravvivate dai giochi virtuosistici dei chiaroscuri, senza impedire la percezione del corpo della Nike, pervaso da uno straordinario effetto di impetuoso dinamismo.
Sempre al XIX secolo risale anche il rinvenimento di un’altra rinomata statua ellenistica: la Venere di Milo, dal nome dell’isola egea di Milo, in cui l’opera si trovava prima di essere trasportata a Parigi, nel Museo del Louvre.

La statua, da ritenersi copia di un’Afrodite che si specchia nello scudo di Achille, è riferibile alla fine del II secolo a.C. e si può inserire in un diffuso filone artistico votato a soggetti più piacevoli ed evasivi: ninfe, satiri e personificazioni dell’Amore.
Le fattezze morbide e sinuose della dea le donano una raffinata sensualità, appena mitigata dalla veste che le cinge i fianchi. Sotto i panneggi s’intravede, poi, il gioco dinamico della gamba sinistra protesa in avanti in un gesto di gran spontaneità.
Mariaelena Castellano
DENTRO L'OPERA
LAOCOONTE CON I FIGLI (fine del I sec. a.C.), marmo, Roma, Musei Vaticani.
Opera dello scultore Agesandro, con la collaborazione dei figli Polidoro e Atenodoro, il gruppo emerso tra le rovine delle Terme romane di Tito nel XVI secolo, desta da subito grande ammirazione ed entusiasmo nell’ambiente rinascimentale italiano.

Come narra il mito, Laocoonte, sacerdote di Apollo, diffida del dono acheo del cavallo di legno, lasciato sotto le mura di Troia e tenta di impedirne l’ingresso nella città. Il suo scetticismo, però, scatena l’ira di Atena, favorevole alla vittoria greca. La dea fa dunque uscire dal mare due grossi serpenti per stritolare il sacerdote e i suoi due figli.
La scultura rappresenta proprio il momento dell’aggressione, raggiungendo un potente grado di drammaticità. I corpi sono avvinghiati nella presa dei due mostri marini e si dimenano tentando di svincolarsi in una serrata tensione dinamica e in un crescendo di enfasi emotiva che perviene a livelli di grande forza espressiva nel volto angosciato di Laocoonte.
IL TORO FARNESE – copia romana degli inizi del III secolo d.C. dall’originale bronzeo, Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
Tra i reperti della collezione Farnese custoditi a Napoli, nel Museo Archeologico Nazionale, figura anche il gruppo scultoreo raffigurante il Supplizio di Dirce, copia romana di un originale in bronzo ellenistico, più conosciuta come Toro Farnese.

La monumentale scultura, nonostante i numerosi restauri, non ha perso la sua intensa carica emotiva, legata a un drammatico pathos, nonché all’energico moto ascensionale che pervade la colossale composizione piramidale.
L’opera racconta del supplizio inflitto alla regina Dirce dai gemelli Zeto e Anfiòne, per vendicare i soprusi subiti dalla madre.
La scena è concitata: i due fratelli legano la donna a un toro imbizzarrito, condannandola a subire una tragica fine.
Le figure, pervase da una gran vitalità, sembrano muoversi nello spazio. Ai gesti serrati e autoritari dei due uomini fa contrasto la disperazione di Dirce, che tenta di suscitare la pietà dei suoi oppressori per evitare il compimento del terribile supplizio.