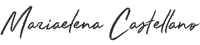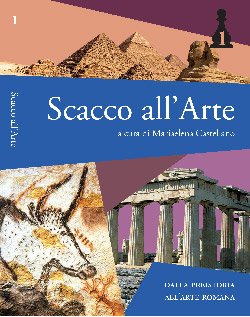Miserere
“Miserère mei, Deus, secùndum magnam misericòrdiam tuam.”
30 marzo 2018, Venerdì Santo
Due rintocchi, giusto due.
Sgusciano sordi dall’orologio del campanile della Basilica di San Michele Arcangelo.
E´quasi ora, ormai.
L’oscurità della notte è smorzata da una gran Luna bianca. Spunta dalle fronde degli alberi, s’intravede tra i palazzi del centro storico di Piano di Sorrento, si fa spazio fra le nubi.

Sembra la stessa di quel Venerdì Santo di cinquant’anni fa.
Mezzo secolo.
Cambiano tante cose nel tempo, ma la Luna no, resta sempre la stessa, lei. Anche se si diverte a mutar faccia con i suoi giochi d’ombra: cresce a piccoli spicchi, arriva a due quarti, diventa piena, per poi rimpicciolirsi fino a sparire e riapparire di nuovo.
Va avanti così, incurante di tutto quel che accade sotto i suoi bagliori.
Il professor Vincenzo Esposito si avvicina alla finestra. Volge lo sguardo in alto, verso questa immensa Luna.
E´ quasi tentato a non uscire più. Sì, forse sarebbe meglio restare a casa.
Altri rintocchi.
Le due e un quarto.
Ormai ha deciso: gira la chiave, spinge con un colpo secco il vecchio e cigolante portoncino di legno, esce di casa.
Fuggire dai ricordi non è servito a nulla: il loro tormento lo ha comunque perseguitato per tutti questi decenni.
Vincenzo sente che è giunto il momento di affrontarli e rivivere ogni istante di quella lontana notte del 12 aprile 1968.
Scende in strada. Arranca tra la gente; si guarda intorno disorientato, il respiro già ansimante.
Scorribande di ragazzini approfittano dell’uscita notturna della processione per far le ore piccole: invadono a ondate i marciapiedi oppure sfrecciano su rumorosi scooter. Genitori trafelati camminano svelti per accompagnare i figlioletti al coro del Calvario, mentre qualche incappucciato fa già capolino dall’ingresso della congrega.
Il corteo dei Neri dell’Arciconfraternita della Morte e Orazione si sta formando.

Sono quasi le tre del mattino, ma questo gran via vai di persone riempie la città e anima la notte.
La notte del Venerdì Santo.
Una piccola folla si accalca nello spiazzale della Basilica in attesa della solenne uscita della Madonna Addolorata, che vagherà alla ricerca del Cristo.
Tra qualche istante la Vergine, illuminata dai soffusi bagliori della Luna e delle lanterne, varcherà la soglia del monumentale portale bronzeo della chiesa.

Le strade del paese per una notte diventeranno quelle della Gerusalemme di duemila anni fa, quelle in cui la Madre, affranta, peregrinava per trovare suo Figlio.
In fondo, ognuno di noi cerca qualcosa in questa vita.
Un amore perso, una persona che non c’è più, una guarigione, un riscatto, una riconquista.
Non si smette mai di cercare.
E lui, Vincenzo, cerca la pace, dopo anni e anni di tormento.
Riesce a intrufolarsi tra la calca di persone, si guadagna un posto in prima fila.
Cinque rintocchi.
Le tre meno un quarto.
I primi incappucciati aprono il corteo dalla sede dell’Arciconfraternita, a pochi metri dalla Basilica.
Avanzano lentamente nel largo dell’Annunziata. Nascosti dalle loro vesti nere, procedono austeri tra i colpi secchi inferti ai tamburi.

Tum, tum, tum.
L’anziano professore d’istinto si porta le mani alle orecchie. Avverte tutta la potenza di quei colpi, se ne sente percosso. Il suo corpo smagrito e consumato dall’inquietudine vacilla.
“Non si sente bene?“, gli chiede una signora, anche lei avanti negli anni.
Vincenzo la riconosce, abita nel palazzo accanto al suo. “Sto bene“, bofonchia a denti stretti e si allontana.
Si lascia alle spalle i tamburi, gli incappucciati, la vicina di casa, la folla.
La donna lo aveva guardato perplessa, ma non lo aveva identificato.
Nessuno riconosce più il vecchio professore. Sono trascorsi cinquant’anni da quando ha preso dimora a Napoli e nessuno fa più caso a lui in terra sorrentina.
Dopo quella tragica notte, dopo quell’alba del Venerdì Santo di mezzo secolo fa, non era più riuscito a restare nei posti di sempre.
Quei luoghi non erano più gli stessi. Erano stati infangati ed era un supplizio per lui continuare ad abitarli, a percorrerli, a viverli.
Così si era trasferito nella città del Sole, in attesa che qualche raggio luminoso rischiarasse le sue giornate buie, trascorse tra pagine di libri, ricerche e relazioni.
Vincenzo si era buttato a capofitto nella carriera universitaria per provare a dare un senso alla sua travagliata esistenza.

L’impegno gli era stato riconosciuto con un’ambita cattedra in Filologia Romanza alla Facoltà di Lettere della Federico II.
“O’ professor”: avevano iniziato a chiamarlo così in Penisola Sorrentina.
Non era da tutti insegnare all’Università: Vincenzo si era guadagnato il rispetto e l’ammirazione dei compaesani. Era diventato un uomo di cultura, un docente impegnato anche in importanti ricerche e pubblicazioni.
Trasferirsi a Napoli, però, non era servito a placare il suo male di vivere.
Fino a quando i suoi genitori furono in vita, di tanto in tanto faceva ritorno nella sua terra natia. Andava a starsene da loro per qualche fine settimana estivo, per la festa di Ognissanti, per le vacanze di Natale. Ma mai per i giorni di Pasqua.
“Perché non vieni? Ci sono le processioni, hai sempre cantato nel Miserere… non ti mancano le tradizioni del tuo paese?“, gli chiedeva ogni anno sua madre.
“Sì, mi mancano“, avrebbe voluto risponderle. Invece, trovava ogni volta una scusa.
Poteva mai dirle la verità?
Lei gli faceva recapitare la pastiera, il dolce della tradizione pasquale. La preparava con quell’amore incondizionato, che solo una madre può provare.

In quell’impasto riversava tutto l’affetto, ma anche la malinconia e la rassegnazione a non averlo più con sé, quel suo unico figlio, così particolare.
Ogni tanto se lo guardava nelle foto. Magro, alto, spalle strette; occhi castani, ma di un marrone così scuro da sembrare nero; occhi dal taglio allungato, occhi tristi e guardinghi.
Era sempre stato sulle sue, Vincenzo, sin da piccolo: Introverso, scontroso, taciturno, Man mano che cresceva, alzava un muro sempre più grande; nemmeno sua madre era riuscita a scalfirlo quel massiccio cumulo di pietre.
Si limitava a ricoprirlo di attenzioni, quelle che avrebbe voluto vedergli ricevere da una moglie. Ma lei suo figlio non l’aveva mai visto con una donna. Mai. Avrebbe voluto saperlo “accasato”, si sarebbe preoccupata di meno così.
Invece, morì con questo pensiero. Era l’estate del 1987. Dopo appena due anni, anche il padre del professore lasciava questa Terra.
I genitori di Vincenzo non c’erano più e con loro nemmeno il pretesto per tornare di tanto in tanto a casa.
Così se n’era restato a Napoli. A occupasi di studi, lezioni, conferenze.
L’emerito professore.
Solo.
Imprigionato com’era nel suo muro, tra i silenzi e le paure.
Ha deciso di uscirne soltanto adesso. Si è aperto un piccolo varco e, tra cumuli e macerie, ha fatto ritorno a casa.
Mancava da ventinove lunghi anni.
Stavolta è rientrato durante la Settimana Santa.

Ne aveva fatto a meno per mezzo secolo di questa suggestiva atmosfera mistica, ne aveva preso le distanze, con la vana speranza di poter dimenticare.
I ricordi, però, continuavano a presentarsi.
Di giorno, di notte. Attraverso visioni, sogni. Memorie mai sopite.
“Miserère mei, Deus, secùndum magnam misericòrdiam tuam.”
Sentiva quel canto polifonico scandirsi nella mente e nell’anima. Ne ricordava ogni parola.
Fuggire non gli era valso a nulla. L’inno del peccatore pentito non lo aveva mai abbandonato.
Ma cinquant’anni sono tanti. Troppi.
La vecchiaia incombe veloce e Vincenzo non può pensare di morire senza prima rivedere le processioni e riascoltare, per un’ultima volta, il coro gregoriano da cui è stato inseguito un’intera vita; anche prima che si consumasse quella terribile notte del 1968. Sì, ne era perseguitato anche gli anni addietro.
“Miserère mei, Deus, secùndum magnam misericòrdiam tuam.”
Già da ragazzino, appena entrato nel coro, quel salmo penitenziale dalla musicalità così grave e solenne si era radicato nella sua acerba e confusa coscienza. Si era aggrappato a quelle parole, le cantava con veemenza, come se in questo modo potesse allontanare ogni turbamento.
Voleva liberarsi da quei pensieri strani, da quelle sensazioni così innaturali, così lontane da ciò che avrebbero desiderato per lui i suoi familiari.
Il canto del Miserere, però, non riusciva a purificargli l’animo. I suoi versi sembravano piuttosto dei capi d’accusa per il suo persistere nel peccato e adesso, che sente la fine vicina, li riascolterà.
Quanto l’ha desiderata questa fine!
Forse già in quella notte di cinquant’anni fa, quando era appena ventiquattrenne.
Sì, avrebbe voluto morire anche lui in quel Venerdì Santo.
Chi lo avrebbe cercato?
I suoi genitori. Nessuno più.
La Processione, intanto, avanza.

La Madonna Addolorata cerca l’amato Figlio, avvolta in una sontuosa veste scura; le mani giunte, il fazzoletto ricamato tra le dita; un regale senso di smarrimento, il dolore scolpito nel volto.
Gli incappucciati reggono con saldezza la divina effigie, eppure la Madre oscilla: fluttua come uno spirito evanescente tra i vicoli e le strade della città, si muove insieme al suo prezioso manto di stelle.
Cerca il Cristo.
“Chi cercherà me?”, si chiede ancora Vincenzo.
“Miserère mei, Deus, secùndum magnam misericòrdiam tuam”, Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia.
Eccolo.
Il coro del Miserere rompe il silenzio della notte.

Le voci vibrano.
Alte, medie, basse, acute.
Si scagliano come frecce, s’insinuano tra il fumo dell’incenso, percorrono gli spazi della città insieme alla Vergine. Sferrano pungenti l’animo già provato del professore.
L’uomo, sfiancato, si porta di nuovo le mani alle orecchie, barcolla, cerca un appiglio per sostenersi. Stavolta non c’è nessuno nei paraggi a chiedergli come stia.
“Et secùndum multitùdinem miseratiònum tuàrum, dele iniquitàtem meam”, Nella tua grande bontà cancella il mio peccato.
Respira a fatica Vincenzo. Avverte tutto d’un tratto l’ingombro della vecchiaia, si sente sovrastare dal peso dei suoi settantaquattro anni.
E poi quelle voci. Quel coro in cui ha cantato da giovane, quelle parole di redenzione.
Le ricorda ancora a memoria, sono ben impresse nella mente.
“Àmplius lava me ab iniquitàte mea, et a peccàto meo munda me”, Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
Chiude gli occhi, ripete tra sé i versetti latini del salmo biblico.
Il tempo si ferma per qualche istante.
Il professore non è più nel suo presente, il passato lo sta bruscamente chiamando a sé.
Vecchie memorie mai placate s’impossessano dei suoi sensi, fino a fargli rivivere lucidamente ogni cosa.
“Miserère mei, Deus, secùndum magnam misericòrdiam tuam …”
12 Aprile 1968, Venerdì Santo
Il giovane Vincenzo intona il canto e ne avverte tutta la tensione. Si concentra sulle parole di questa solenne melodia, le lascia vibrare nell’anima.
“Quòniam iniquitàtem meam ego cognòsco, et peccàtum meum contra me est semper”, Le mie colpe io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Non accusa il freddo della notte. Anzi. Si sente accaldato, ha il volto arrossato. Sarà per l’agitazione di tutti i suoi pensieri.
Da diversi anni prova con tutte le sue forze a reprimerli, ma essi riemergono dispotici, si divertono a inquietarlo.
Quale nome dare a questi tormenti? Non si può dare nessun nome a una verità così scomoda da accettare.
“Tibi, tibi soli peccàvi, et malum coram te feci, ut justificèris in sermònibus tuis, et vincas cum judicàris”, Contro di Te, contro Te solo ho mancato, quello che è male ai Tuoi occhi io l’ho fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nei Tuoi giudizi.”
Il coro canta, ma dalle labbra schiuse di Vincenzo non escono più suoni. Ascolta le altre voci, vorrebbe unirsi a loro, ma non riesce a emettere alcuna parola.
Avverte un senso di vertigine, la vista gli si annebbia: Lorenzo Schisano è lì, davanti a lui.
Si fa spazio tra le fiammelle delle candeline adagiate sui marciapiedi, ancora fomentate dal fumo vaporoso degli incensieri.

E´lì da solo. Ha scelto di guardare la processione in una stradina secondaria, dove non c’è quasi nessuno.
Eccolo, gli appare in tutta la sua seducente beltà.
L’oscurità della penombra non impedisce il risalto di quella corporatura statuaria, così alta e possente.
La Luna bianca schiarisce il volto del suo Adone e Vincenzo può apprezzarne i lineamenti delicati, incorniciati dalle lunghe ciocche di capelli biondi.
Tra i bagliori lunari può scorgere anche i suoi occhi, grandi e verdi.
I loro sguardi s’incrociano per qualche secondo. Lorenzo gli sorride. Lui, invece, distoglie gli occhi da quel viso amato e detestato al tempo stesso.
Si concentra sul canto.
“Ecce enim in iniquitàtibus concèptus sum, et in peccàtis concèpit me mater mea. Ecce enim veritàtem dilexìsti: incèrta et occùlta sapièntiae tuae manifestàsti mihi”… Ecco, io sono generato nella colpa, concepito dagli ardori di mia madre. Ma Tu vuoi la sincerità del cuore, e nella mia notte, mi fai conoscere la sapienza.

La processione avanza lenta, svelando man mano tutta la litania dell’antico salmo biblico.
Vincenzo recita i versi, ma la sua mente è altrove.
Vorrebbe non sentirsi così lusingato dalle attenzioni del suo amico. Eppure, i suoi pensieri restano impigliati in quell’incrocio di sguardi, in quel sorriso apparso tra le luminescenze delle fiaccole accese.
Sono anni che tenta di allontanarsi da questi contrastanti sentimenti.
Lo ha conosciuto tra i banchi di scuola, Lorenzo.
Le elementari, le medie, il liceo: sempre nella stessa classe, sempre compagni di banco. Si sentiva protetto quando gli stava vicino, lo ammirava da sempre.
Emozioni bisbigliate, sospese, ma mai ammesse.
Troppo difficili da far proprie, incastrate com’erano in una volontà altra. No, non era questa la direzione stabilita, non si poteva deragliare dalla retta via della normalità.
Sarà allora questa la normalità? Fingere che nulla sia?
Sì, Lorenzo è solo un caro amico d’infanzia con cui studiare e fare una chiacchierata.
Se solo smettesse di cercarlo, di stargli così addosso con quegli sguardi invasivi e quei sorrisi intriganti.
Dovrebbero evitarsi, per il bene di entrambi; ma Lorenzo non fa nulla per essere evitato.
Eccolo, di nuovo. Ha seguito la processione e poi l’ha affiancata per poter rivedere Vincenzo.
Ancora occhi negli occhi. Ancora un sorriso.
Le fiaccole, l’incenso, gli incappucciati, il canto gregoriano…
“Aspèrges me, Dòmine, hyssòpo, et mundàbor; lavàbis me, et super nivem dealbàbor”, Purificami con issòpo e sarò mondato; lavami e sarò bianco ancor più della neve.
Vincenzo canta con tutto il fiato che ha in gola, come se insieme alla voce potesse buttar fuori anche la confusione, la paura, la rabbia.
E´un crescendo di tensioni. Non gli danno tregua, lo annientano.
Ha il respiro corto, la voce sembra mancargli di nuovo, la fronte è madida di sudore.
Nemmeno Lorenzo gli dà tregua. Ricompare una terza volta, continua a guardarlo con insistenza.
Segue la processione fino al suo scomporsi in chiesa; s’infila tra gli incappucciati che depongono le croci ai piedi del sepolcro.

Le prime luci dell’alba attraversano le sontuose navate della basilica di San Michele.
Fuori un via vai di gente anima lo slargo antistante le scale d’ingresso; Vincenzo lascia il coro e si defila veloce, tenta di confondersi tra la gente.
Sa di avere lui alle spalle e tira dritto verso casa.
Pochi minuti e troverà riparo tra le spesse mura di tufo della sua abitazione, in pieno centro storico, nelle vicinanze della trecentesca cappella di Santa Margherita.

Lorenzo continua a stargli dietro, inutili i tentativi di distanziarlo.
“Non puoi continuare a evitarmi!“, gli dice, quando finalmente riesce a raggiungerlo e afferrargli un braccio.
Vincenzo si sente braccato, costretto a una resa dei conti da cui aveva sempre cercato di fuggire.
Vorrebbe lasciarsi andare e, per una volta, assecondare i suoi istinti più veri.
Vorrebbe abbracciare quell’uomo per trovare finalmente conforto in lui.
Forse insieme potrebbero affrontare tutte le paure, tutti i dubbi.
Oh sì, vorrebbe stringerlo forte tra le sue braccia.
Ma è solo un attimo di debolezza. Un solo breve istante, uno stralcio di fugaci pensieri indefiniti.
Si svincola dalla sua presa e si allontana.
Corre, imbocca il vicoletto di casa, è quasi arrivato.

Ma Lorenzo gli è ancora dietro.
Vincenzo lo ignora.
Se potesse avere sentore dell’imminente destino, magari si fermerebbe.
Se sapesse di non poterlo rivedere mai più, forse proverebbe a vincere ogni paura e lo stringerebbe forte a sé.
Invece, per l’ennesima volta, non riesce a liberarsi dai suoi timori.
Seguono altri brevi istanti di incertezza, finché all’improvviso il volto del suo amico diventa una maschera di paura, gli occhi imprigionati in una morsa di terrore e incredulità.
Gli resteranno impressi quei grandi occhi verdi divenuti vitrei.
Li vedrà per tutta la vita.
Sentirà la voce stridula di Lorenzo, soffocata tra gli ultimi disperati e flaccidi respiri.
Rivedrà più e più volte quelle due mani affusolate scagliate con veemenza contro il suo amico, per poi stringerne forte la gola, fino a privarla di ogni anelito di vita.
Piange Vincenzo, piange tutte le sue lacrime.
Prova a smuovere quel corpo ormai immobile, cerca di sentirne il respiro.
Gli occhi sono ancora spalancati, glieli richiude e osserva per un’ultima volta il suo bel viso, ora inghiottito dal cereo pallore della morte.
Lorenzo è stato assassinato. Se ne è andato senza un suo abbraccio, senza una spiegazione, una verità.
Vincenzo ha un senso di vertigine, si accascia, gli gira la testa.
Sente ancora le voci del Miserere sbattergli forte nelle tempie.
Quelle voci lo seguiranno ovunque, si radicheranno insidiose nella sua memoria.
“Audìtui meo dabis gàudium et laetìtiam, et exsultàbunt ossa humiliàta. Avèrte fàciem tuam a peccàtis meis,
et omnes iniquitàtes meas dele. Cor mundum crea in me, Deus, et spìritum rectum ìnnova in viscèribus meis”, Fammi sentire letizia e gioia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli il Tuo sguardo da ogni mio peccato, cancella tutte le mie colpe. Crea in me un cuore puro, o Dio, rinnova in me uno spirito saldo.
30 marzo 2018, Venerdì Santo
Albeggia.
La Madonna Addolorata rientra tra le mura del suo tempio.

Questa sera uscirà di nuovo, insieme al Cristo Morto.
Vagherà ancora per le strade del paese, piangerà le lacrime della Madre che sopravvive al proprio Figlio.
La Basilica di San Michele si sta svuotando. Gli ultimi incappucciati neri attraversano le navate, si ritirano nella congrega dell’Arciconfraternita della Morte e Orazione.

Fuori ancora qualche persona.
L’anziano professore è appoggiato alle impalcature che da qualche settimana schermano l’elegante facciata barocca della chiesa.
Tossisce, ha il respiro corto. Sente ancora l’umidità della notte nelle ossa.
S’incammina verso casa, come cinquant’anni fa.
Si volta e davanti ai suoi occhi c’è il giovane Lorenzo.
Scaccia questa visione e tira dritto, ma nelle sue orecchie ritornano solenni i versi del Miserere.
“Ne proìcias me a fàcie tua, et Spìritum sanctum tuum ne àuferas a me. Redde mihi laetìtiam salutàris tui, et spìritu principàli confìrma me”, Non respingermi dalla Tua presenza e non privarmi del Tuo santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, e lo spirito generoso mi sostenga.
Non ne può più.
Sarebbe dovuto morire lui, così introverso e schivo; non Lorenzo, sempre affabile e sorridente.
Procede a piccoli passi, senza seguire più la direzione di casa.
Si ferma in pieno centro, entra nel bar che frequentava da giovane. Il locale è stato ristrutturato ed è completamente diverso dall’ultima volta in cui vi era stato. Le cose cambiano in trent’anni.

Sono appena le sei, ma il bar, rimasto aperto per tutta la lunga notte delle processioni, è già pieno.
Il professore sorseggia con lentezza il caffè ancora fumante. Amaro, come sempre.
Anche Lorenzo lo prendeva senza zucchero. Ne avevano bevuti tanti insieme, proprio qui, al “Gran Caffè Marianiello”.
Quanti ne avrebbero potuti bere ancora, se le cose fossero andate diversamente?
La tazzina traballa sul bancone, il cucchiaino cade. Vincenzo è spossato, ha di nuovo il fiato corto.
La fine è vicina, sì.
La barista si avvicina per soccorrerlo, ma lui preferisce alzarsi da solo.
“Sto bene, sto bene“, ripete più volte, come se volesse convincere anche se stesso.
Raccoglie tutte le forze per trascinare quel corpo malandato e stanco nella parte più interna del locale.

Si accomoda a un tavolo, prende la sua vecchia Montblanc e scrive di getto una lunga lettera.
La mano fredda e tremante non gli impedisce la consueta eleganza dei caratteri. L’inchiostro scorre fluido lungo il pennino per depositare su quei fogli una verità taciuta per troppo tempo.
Vorrebbe gridarla al mondo intero, adesso, questa verità.
Il via vai di persone che animano il bar non lo distrae.
Cappuccini, cornetti caldi, sigarette.

Il professor Esposito, però, è altrove.
E´tornato a quell’alba del 12 aprile 1968.
Si rivede, giovane, a pochi metri dal portone di casa sua, vicino all’ingresso della cantina di famiglia.
Rivede il corpo senza vita di Lorenzo accasciato davanti a quella piccola entrata sormontata da una finestrella a grate.
Vincenzo ne ricorda gli occhi, grandi e verdi, spalancati di paura.
Insieme a quegli occhi, tornano anche altri versi del salmo gregoriano…
“Docèbo inìquos vias tuas, et ìmpii ad te convertèntur. Lìbera me de sanguìnibus, Deus, Deus salùtis meae: et exsultàbit lìngua mea justìtiam tuam. Dòmine, làbia mea apèries, et os meum annuntiàbit làudem tuam”, Insegnerò le Tue vie agli erranti, i peccatori a Te torneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, e la mia lingua esalterà la Tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la Tua lode.
Le sette e un quarto.
Vincenzo si alza lentamente; chiude la busta, la piega a metà per poterla contenere nel palmo della mano. Quindi esce dal bar e scende verso Piazza della Repubblica.
A un certo punto si ferma, riprende la busta con su scritto “Al Comandante dei Carabinieri di Piano di Sorrento” e aggiunge: “Importante!”

Quando arriva dinanzi alla caserma, il portone è ancora chiuso.
“Apre alle otto“, gli svela un passante. Tre quarti d’ora sono troppi, non può aspettare.
Infila la lettera sotto le ante lignee dell’ingresso e torna a casa.
Quarantacinque minuti dopo il maresciallo Paolo Castaldi apre il portone di Casa D’Arma e, nel varcare la soglia, nota subito una busta bianca sul pavimento. La raccoglie, ne osserva l’intestazione, la grafia accurata.
Questa busta così spessa lo ha incuriosito, sembra contenere molti fogli al suo interno.
Crede sia opportuno aprirla quanto prima. C’è anche scritto “Importante!”.
Si accomoda alla postazione della piccola guardiola d’ingresso e contatta il suo superiore per informarlo.
“Una lettera per me? No, non la apra, attenda il mio arrivo. Sarò in caserma al massimo tra un paio d’ore”, gli risponde il comandante Armando Baschi.
A metà mattinata i due militari sono dinanzi all’ingresso dell’appartamento del professore.
Con loro c’è anche il brigadiere Pasquale Petracchi, che con la sua stazza massiccia sfonda il vecchio e cigolante portoncino ligneo di casa Esposito.
Troppo tardi.
Nel silenzio di quelle stanze vuote c’è il corpo senza vita di Vincenzo.
E’ accovacciato su una poltrona, gli occhi socchiusi, le labbra livide serrate; tra le mani un flacone vuoto di psicofarmaci.
“Vincenzo, cosa mi hai combinato?“, sussurra tra i denti l’anziano luogotenente.
Anselmo Baschi ricorda ancora l’immagine di quel giovane magro, con gli occhi scuri scuri, sempre sulle sue, l’aria imbronciata.
Frequentava la stessa classe di suo fratello maggiore, al liceo.
Era sempre stato strano Vincenzo, ma adesso il comandante comprende ogni cosa di quegli atteggiamenti così ritrosi ed inquieti.
Mentre il maresciallo Castaldi scatta le prime foto per la rilevazione dello stato dei luoghi, Baschi si accomoda in una delle sedie del soggiorno.
Intorno a lui, mobili polverosi, arredi dimenticati da un tempo troppo lungo.
Il comandante compone il numero del procuratore per informarlo del caso, quindi rilegge per l’ennesima volta la lettera del professore.

In quei pensieri impressi sulla carta affiora tutto il tormento di quell’uomo.
Al comandante sembra di avere davanti agli occhi la scena dell’uccisione: il giovane Vincenzo non regge più il peso del suo stato confusionario e si scaglia contro l’amico, colpevole di quella peccaminosa seduzione.
Vincenzo sembra un ossesso, ormai non è più in sé. L’inquietudine accumulata negli anni esplode in pochi attimi di follia.
Lorenzo, incredulo, si ritrova con il collo imprigionato tra le mani del suo amico di sempre.
Pochi secondi, pochi drammatici istanti, poi l’impeto feroce della stretta lascia il posto al delirio.
La mente del carnefice, sgomenta, non riesce a realizzare con lucidità quanto accaduto.
No, quelle mani assassine non erano le sue.
No, non è stato lui a compiere questo gesto assurdo. Non può essere stato lui.
Al senso di incredulità sopraggiunge la paura di essere scoperto e il timore di infliggere un dolore troppo grande ai suoi amati genitori.
Trascina il cadavere nella cantina. Lo infila in un vecchio baule, nell’anfratto più nascosto di quello stanzino polveroso, in un cunicolo roccioso, che si guarda bene di ricoprire con pesanti tavole di legno.

Prima di lasciare quello spazio di morte, piange tutte le sue lacrime.
Ma Lorenzo non può sentirlo. Resta lì, immobile, sepolto in quella bara dell’oblio, destinata a essere sua anonima dimora per mezzo secolo, prima che il misterioso caso della sua scomparsa, verrà svelato.
Il comandante Baschi era poco più che bambino, ma ricorda bene lo scalpore di quella tragica notizia: uno dei compagni di classe di suo fratello era scomparso all’improvviso e nessuno ne aveva più sentito parlare. Un fatto di gran clamore in Penisola Sorrentina, ma le indagini non avevano portato a nulla e col tempo il caso era stato archiviato.
Nessuno avrebbe potuto immaginare quell’efferato delitto. Nessuno avrebbe potuto pensare chi si nascondeva dietro la sparizione del giovane Lorenzo Schisano.
Armando Baschi scruta il volto pallido del professore, congelato nella freddezza di una morte cercata.
Sempre così rispettoso, mansueto. Chi mai l’avrebbe pensato nelle vesti di un dissennato omicida?
Il comandante rilegge l’ultima parte della confessione epistolare di Vincenzo, dove svela del suo rientro a casa, in quell’angosciante alba di cinquant’anni fa, quando dopo aver chiuso il catenaccio della cantina, si portava le mani alle orecchie, per non ascoltare le voci del Miserere. Quel canto gli rimbombava nella testa e non riusciva più a liberarsene:
“Quòniam, si voluìsses sacrifìcium, dedìssem ùtique: holocàustis, si òffero, non delectàberis. Sacrifìcium Deo spìritus contribulàtus: cor contrìtum et humiliàtum, Deus, non despìcies.
Benìgne fac, Dòmine, in bona voluntàte tua Sion, ut aedificèntur muri Jerùsalem. Tunc acceptàbis sacrifìcium justìtiae, oblatiònes et holocàusta; tunc impònent super altàre tuum vìtulos”.
Poiché il sacrificio Tu non gradisci, e, se io offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, Tu, o Dio, non disprezzerai.
Nel Tuo amore fai grazia a Sion, le mura rialza di Gerusalemme. I sacrifici prescritti allora gradirai, l’olocausto e l’intera oblazione: allora immoleranno vittime sul Tuo altare.
Il professore ha concluso la sua lunga lettera proprio con questi ultimi versi del canto gregoriano.
Prima di firmarsi, ha poi scritto:
“Raggiungerò finalmente la pace, il Dio Padre mi perdonerà?
Non ha forse il Cristo affrancato il buon ladrone, dicendogli che sarà con lui in Paradiso?
Una salvezza scandalosa, questa, che fa ben sperare nella grandezza del perdono divino.
Mi pento, mi pento di tutto… abbi pietà di me, o Dio. Miserere mei !”
Vincenzo Esposito
Mariaelena Castellano
Ringrazio Mariano Russo (Rusma Photo) per i suggestivi scatti dei riti processionali della Settimana Santa in Penisola sorrentina.
Ringrazio, inoltre, l’Arma dei Carabinieri di Piano di Sorrento per avermi fornito le opportune informazioni sulle procedure operative inerenti questa narrazione.
(Per altri racconti della collana Casa d’Arma, cliccare QUI).