Sailing
Non esistono le bugie a fin di bene, perché alla fine il bene le travolge, le assimila, le plasma e le trasforma in verità relative. Verità relative come quelle che custodiscono Nadia ed il suo piccolo Matteo, in questo secondo racconto “evaso” dalla penna della nostra Mariaelena.
Un racconto che è di tutti ed è di nessuno.
Un racconto che è l’essenza di quel cordone ombelicale che lega per sempre una madre al proprio figlio.
Johnny Pollio
Un cielo di favole
Un aereo in volo disegna una scia bianca nel cielo azzurro. Soffermo lo sguardo su questa densa striscia di nebulosa, che man mano si dirada. magari potessero dissolversi così anche tutti i miei dubbi, i segreti, le paure…
Lascio andare un sospiro. Ho un groppo alla gola e, negli occhi, lacrime a cui non consento di scorrere.
Mi sento osservata dalle persone che ho intorno. Oggi il Curreri che da Sorrento conduce all’aeroporto di Capodichino è più affollato del solito.
Matteo è impegnato a guardare fuori dal finestrino, attratto dal passaggio degli aerei. Ogni tanto si volta verso di me. Io resto taciturna, persa nei miei pensieri. Oramai si sarà abituato a questi miei prolungati silenzi; avrà compreso che quando sono assorta, è bene lasciarmi stare. Tanto, si tratta di una manciata di minuti; poi, torno alla realtà, scrollandomi di dosso tutto il cielo di favole inventato per lui.
Un aereo plana verso la pista d’atterraggio, il rombo del motore si sente fin qui. Mi porto le mani alle orecchie e penso che sarà quasi un anno che veniamo in questo aeroporto per almeno un paio di volte al mese.
«Mamma, chissà qual è il suo aereo!» esclama il piccolo Matteo sfoderando uno di quei suoi sorrisi pieni di vita. È così entusiasta, da farmi sentire ancora più sbagliata.
L’autobus si accosta, siamo arrivati al capolinea, lo annuncia anche l’autista: «Capodichino, ultima fermata, Naples airport.»
Nemmeno il tempo di scendere, che il mio bimbo già si affretta verso l’ingresso dell’aeroporto. Aumento il passo per raggiungerlo, mentre lui saltella felice tra il via vai di persone che affollano lo spiazzale.
«Mammaaa, non fare la lumaca, dai!» mi esorta mentre procede spedito, muovendosi con scaltrezza tra le porte a vetro e le scale mobili.
Ha soltanto quattro anni e mezzo, ma è già fornito di un buon senso dell’orientamento. Del resto, conosce bene questo posto. Dovrei sapermi destreggiare anch’io e invece, ogni volta, avverto un gran senso di spaesamento.
Sarà per tutta la situazione.
Costruire castelli di sabbia può andar bene fino a un certo punto, ma prima o poi finisce che anche la roccaforte più stabile si sgretoli.
Il mio Matteo meriterebbe una vita più stabile, senza le mie invenzioni fantasiose, senza più bugie.
Eppure, è sempre così allegro, specie quando approdiamo qui, dove si diverte a guardare le vetrine dei negozi e a far su e giù per le scale mobili. Scruta con curiosità l’andirivieni dei viaggiatori; schiaccia fronte e nasino sulle ampie vetrate che danno sulla pista; guarda gli aerei in arrivo, il transito delle navette.
Questo posto è il suo parco giochi, il suo paese dei balocchi.
Per me, invece, è il luogo in cui le mie menzogne si scontrano bruscamente con la realtà.
«Mammina, sediamoci nel nostro ristorante!»
Il nostro ristorante.
Sì, perché questo aeroporto è un po’ come una seconda dimora per noi; una grande casa dove trascorriamo intere ore e dove, tra i negozi e le sale d’attesa, oramai abbiamo delle tappe fisse.
Innanzitutto, il McDonald, il nostro ristorante: il grande salotto proiettato sul mondo, dove scegliamo quasi sempre lo stesso menù.
Ci accomodiamo e, non appena prende posto, Matteo apre il suo zainetto; in men che non si dica il tavolo è invaso da macchinine, figurine e libretti da colorare.
Lo osservo mentre è concentrato a disporre le sue cose, a giocarci, a riporle di nuovo nello zaino, per poi riprenderle ancora.
Dopo un po’, siamo di nuovo nei grandi spazi vetrati dove transitano turisti, forze dell’ordine, hostess e addetti ai servizi.
Ci mescoliamo tra loro. Intorno a noi, un microcosmo di persone alle prese con valigie, ritardi, attese, check in. Noi, invece, no. Nulla di tutto questo. Siamo degli intrusi. Nessuna valigia, niente arrivi, né partenze. O meglio, un arrivo c’è, ma… immaginario.
Dio mio, come sono arrivata a questo punto?
All’inizio sembrava un’idea come un’altra, buttata fuori così, per temporeggiare e per proteggere Matteo da una verità troppo difficile da spiegare.
Poi, ne è uscito fuori tutto un crescendo di bugie, inventate con grande abilità, tanto da crederci quasi anche io.
«Nadia, hai agito in buona fede, ma hai fatto un grave errore: non devi mai mentire a tuo figlio. Così facendo, lo confondi e lui non avrà più fiducia in te.»
Ha esordito così, ieri, una mia cara amica psicoterapeuta.
Saranno mesi che avevo in mente di chiederle un consiglio, ma ogni volta cambiavo idea. Credevo di riuscire a gestire tutto da sola, invece, sentirmi dire le cose come stanno da una voce autorevole, mi ha donato più consapevolezza.
Ho compreso di non poter rimandare più, di dover interrompere questa farsa il prima possibile.
Mi sembra di sentire ancora le sagge parole della mia amica: «Ai bambini va sempre detta la verità. Anche se dolorosa, loro trovano il modo giusto per accettarla. E poi, ricordati che la percepiscono. Sono come una spugna: assorbono tutta la realtà da cui sono circondati, molto più di quanto possiamo immaginare.»
Cosa avrà assorbito Matteo da questa nostra realtà?
Io e lui, in 30 metri quadri, in un monolocale al piano terra, giù la marina di Cassano, a Piano di Sorrento.
Io e lui, a trascorrere la sua infanzia tra fili di biancheria stesa e rimesse di barche; a guardare i voli dei gabbiani e le lenze dei pescatori. E poi, il mare. Per perderci nel suo orizzonte e lasciarci affondare dentro tutti i nostri sogni.
Io e lui, a muoverci sempre in autobus o a piedi, a passo lento e con il respiro veloce, salendo le ripide tese che dalla spiaggia ci portano al centro abitato, tra i palazzi storici, i giardinetti, i vicoli e gli affacci panoramici.
Quando invece arriviamo qui, a Capodichino, Matteo si lascia avvolgere dalla modernità di questa struttura aeroportuale, ne respira l’aura d’internazionalità. Avverte di trovarsi in una realtà diversa da quella più quieta in cui viviamo.
Spesso gli parlo di Napoli, di questa capitale europea a un passo da noi, così pulsante di vita e di energia, sempre in bilico tra il vecchio e il nuovo, un crogiolo dove antiche tradizioni dialogano con proiezioni più avveniristiche.
Un dualismo che si ripropone anche qui, in questo spazio aeroportuale definito da un design contemporaneo, in cui però fanno capolino le divinità alate dei musei archeologici campani.
«Guarda queste statue, mamma!» esclama Matteo, indicandole.
Gli racconto di dei con le ali e di eroi mitici, di titani e di ninfe; poi, gli parlo di musei e di scultori. Lui ascolta con interesse. È bello trasmettergli quel che so. Mi fa sentire utile, importante. Mi fa dare un senso a quella pergamena da 110 e lode, racchiusa in un cassetto a prender polvere, insieme a tutti i miei sogni di ieri.
Prima o poi, avrò il coraggio di aprirlo quel cassetto. Adesso, però, c’è Matteo. È lui la mia priorità.
Mi arrangio con lavori di ogni tipo per arrivare a fine mese senza fargli mancare nulla; posso contare anche sugli aiuti del comune e della parrocchia. A volte ho paura di non farcela, ma alla fine riesco sempre a rialzarmi, più forte di prima.
Ogni tanto ripenso al grande attico al centro di Sorrento, dove sono nata e dove ho vissuto fino a pochi anni fa.
Adesso lì ci abita soltanto mio padre.
«Nadia, mi hai dato un gran dispiacere. Da te non mi aspettavo una cosa del genere» inveì, in un caldo pomeriggio estivo di cinque anni fa.
Queste sue parole mi rimbombano ancora nella testa, come se le stesse pronunciando altre dieci, cento, mille volte.
Non c’è giorno in cui non le ricordi.
Io mi limitai a fissarlo senza proferire parola. L’indomani, me ne andai di casa.
Forse, se mia madre fosse stata ancora viva, le cose sarebbero andate diversamente.
Oppure no. In fondo, è sempre stata succube di mio padre, il severo e autoritario capo famiglia, l’illustre giudice di pace, pronto a puntare il dito anche verso i familiari. Il suo verdetto nei miei confronti ha parlato chiaro: colpevole senza assoluzione.
Aspettavo un figlio senza rivelargli chi ne fosse il padre. Un figlio che porta il mio cognome e gli occhi blu del suo papà.
Un uomo complicato, il papà di Matteo; ormai è scomparso dalla mia vita e non l’ho mai informato dell’esistenza di un figlio.
Il mio, di padre, ha ragione: sono colpevole: per tutti gli sbagli, le fragilità e le bugie.
Ma di una cosa, almeno, voglio essere fiera. Avrei potuto tener stretta la mia bella vita tra le quattro mura dell’attico di famiglia, avrei potuto continuare i miei studi letterari, prendere delle specializzazioni…
Adesso avrei un’esistenza completamente diversa, lontana dagli stenti e dalle privazioni.
Ma che vita sarebbe la mia, senza Matteo?
Questo nome non è stato scelto a caso, significa “dono di Dio”.
L’arrivo di un bimbo è sempre un dono. Il mio piccolo Matteo è un grande dono e non merita più di ascoltare bugie, se pur dette a fin di bene, per creare l’illusione di una vita più… Più normale.
Che poi, in fondo, è una gran bella normalità anche la nostra.
Insieme siamo un duetto invincibile. Lui mi ha dato davvero tanto e io, adesso, gli devo la verità.
Vorrei avere il coraggio di confessargli tutto, di dirgli le cose come stanno: «Tuo padre non è un pilota di aerei super impegnato, che vola senza sosta da un capo all’altro del mondo. Tuo padre non te l’ha portato via il lavoro, permettendoti soltanto di salutarlo dietro una vetrata, mentre plana o decolla dalla piste.»
Potrà mai perdonarmi per avergli raccontato queste fantasie?
Quando un annetto fa, in un caldo pomeriggio d’estate, ha iniziato a farmi domande su chi fosse il suo papà, sono andata in panico.
Eravamo al mare, stavamo sfogliando un libro illustrato con immagini di aerei. In un attimo mi è venuta fuori questa favola.
«Ti prego, portami all’aeroporto per salutare il mio papà!» mi aveva implorato lui, qualche giorno dopo.
Va bene, andiamo.
Matteo era entusiasta dei miei racconti sul suo genitore, sul pilota sempre indaffarato, che sale e scende da un aereo all’altro, senza mai fermarsi. A poco alla volta aveva iniziato a immaginarselo quasi come un supereroe, questo suo misterioso papà.
Ho avvertito da subito la necessità di non creargli troppe illusioni, di proteggerlo dalle mie disperate bugie: «Tesoro, anche se andremo in aeroporto, non potremo vederlo … Sai, lui non scenderà dall’aereo…»
Matteo non si era perso d’animo, gli occhi sorridenti, luccicanti per l’emozione di poter vedere l’aereo con il suo papà a bordo: «Allora lo saluto da lontano con la mano. Tu mi dici qual è il suo aereo e io lo saluto! Che ne pensi?»
Da quel giorno siamo venuti qui sempre più spesso e ogni volta abbiamo aggiunto una pagina al copione di questo film.
Una pellicola troppo lunga. È arrivato il momento di uscire dalle fantasie e prendere atto della realtà.
Osservo Matteo mentre corre spedito. Sta giocando a nascondino con un bimbo giapponese un po’ più grande di lui. Poi, si avvicina a una signora anziana, le sorride. Lei gli dà a parlare, sembra divertita. Chissà di cosa staranno chiacchierando.
Abbiamo fatto tante conoscenze qui, in tutti questi mesi. Uomini, donne e bambini provenienti da ogni dove, con i loro bagagli di vita e di emozioni. Da ognuno di loro abbiamo appreso qualcosa.
«Mamma, guarda, arriva un aereo! È quello di papà?»
Matteo ha appena avvistato un aeroplano che sta atterrando.
Non gli rispondo. Lui si avvicina e mi ripete la domanda.
Che bel faccino che ha, così innocente, gioioso. Gli accarezzo prima i capelli, poi le guance. Lo prendo in braccio e gli sussurro nell’orecchio: «Lo sai che la mamma ti vuole tanto, tanto bene, vero?»
«Siiii! Anche io ti voglio bene! Allora, quello è l’aereo di papà, sì o no?»
Respiro forte e raccolgo tutte le energie di cui ho bisogno.
«Matteo, devo dirti una cosa. Ho creato una favola, volevo farti felice e ho inventato per te la storia del papà pilota …»
Il mio bimbo resta in silenzio, punta i suoi grandi occhi blu nei miei, per una manciata di secondi lunghi un’eternità.
Poi, sorride ed esclama, abbracciandomi: «Oh, mamma, lo so già: io non ho un papà. Noi, però, facciamo finta che c’è e che fa il pilota, va bene?»
M.C.

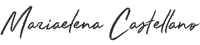



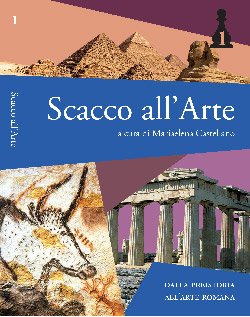
Bellissimo, emozionante e di spessore nella semplicità della stesura che è dei grandi scrittori complimenti.
Grazie mille!